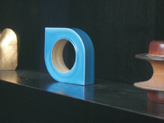Archivi aperti ai volontari
Il riordino, l'inventariazione e la valorizzazione degli archivi passa anche dal prezioso apporto di cittadini giovani, meno giovani e diversamente abili
Luigi Contegiacomo - Presidente ANAI Veneto
Stando alle statistiche e agli esiti sui dibattiti sempre più frequenti sul vertiginoso calo dell'impegno in politica da parte dei nostri giovani, desiderosi di contare e di portare la loro voce, ma purtroppo troppo spesso inascoltati dai centri decisionali, si scopre al contrario che un'altissima percentuale di giovani cerca in altri percorsi e in altri obiettivi la propria realizzazione o quanto meno il proprio desiderio di essere utili alla società in maniera trasversale a fedi e convinzioni politico-religiose. Il volontariato è divenuto oggi il collante dei tanti milioni di giovani e giovanissimi che vedono in questo una risorsa straordinaria in cui formarsi un'identità non convenzionale e trovare o ritrovare se stessi.Ciò non vale unicamente per il volontariato sociale e nel cooperativismo internazionale, ma anche in un campo più ristretto, ma di grande suggestione e potenzialità, quale è quello dei beni culturali. In un paese come l'Italia, dotato di un patrimonio artistico-culturale unico al mondo, tanto che si arriva a pensare ereticamente che sia "fin troppo", il numero delle associazioni di volontariato che si occupano di beni culturali è aumentato in maniera proporzionale al calo delle risorse umane ed economiche di quelle istituzioni che a tali beni dovrebbero provvedere e che tali beni dovrebbero tutelare e salvaguardare. Ed ecco che, a fronte di un calo spaventoso negli ultimi anni dei finanziamenti per musei, biblioteche, archivi, che conduce inevitabilmente alla chiusura di molti luoghi della cultura italiani, a fronte di un rapido calo, oramai irreversibile, delle risorse umane, con il mancato avvicendamento dei pensionati con giovani e fresche leve, pur sfornate a migliaia dagli atenei, si assiste a un aumento esponenziale delle organizzazioni di volontariato, ma forse ancor più del volontariato individuale, magari veicolato da organizzazioni laiche o religiose, se non spesso dalle stesse parrocchie o dalle amministrazioni comunali, proprietarie di biblioteche, raccolte artistiche, archivi.
Ecco che quindi ad Associazioni come le Auser, che promuovono e valorizzano con intelligenza la terza età (ma non solo), facendo dei meno giovani veicoli di esperienze, professionalità, intuizioni, altrimenti destinati alla dispersione e all'inerzia, si affidano oltre che la collaborazione alla gestione di musei, di biblioteche, mostre etc., anche riordini o gestioni di piccoli archivi, fianco a fianco con operatori di parrocchie e biblioteche locali. Molto importante è soprattutto l'apporto che tali volontari possono dare alla valorizzazione: si pensi a quanti insegnanti in pensione, appassionati di storia e di conoscenza, si prestano a ricostruire tramite archivi comunali e parrocchiali, ma non solo, la storia della propria comunità, delle famiglie che la compongono, delle realtà lavorative e aziendali che costellano lo sviluppo dei nostri centri urbani o l'evoluzione dei nostri borghi agricoli. A tali associazioni che possiamo in qualche modo definire trasversali alle componenti sociali e che si avvalgono spesso di "ex" dipendenti, desiderosi di offrire ancora il loro contributo alla società, si aggiungono le associazioni di elitè, come Lions Club, Rotary, etc., spesso coinvolte nella valorizzazione se non addirittura - e al dire il vero non sempre opportunamente quanto a scientificità - nel riordinamento e inventariazione di archivi, sia pur in genere sotto il controllo degli organi deputati alla vigilanza su tali preziosi beni culturali, come le Soprintendenze Archivistiche.
Potenzialmente di grande interesse potrebbe essere l'impegno in alcune realtà locali di persone diversamente abili (associate o in forma individuale), le cui conoscenze, professionalità, attitudini potrebbero offrire un apporto non trascurabile alla conservazione, restauro, valorizzazione del patrimonio archivistico italiano, contribuendo con competenza anche maggiore dei professionisti veri e propri agli allestimenti di mostre documentarie e di percorsi non convenzionali, grazie alla maggiore percezione delle problematiche che spesso impediscono l'accesso ai siti della cultura da parte di portatori di handicap motori, visivi, uditivi, ma anche, perché no, psichici. Si pensi alla possibilità di creare con loro e per loro percorsi tattili, olfattivi, multimediali alternativi, che non possono e non devono limitarsi solo ai grandi luoghi della cultura, ma che devono essere allestiti anche nelle più modeste realtà locali, compresi gli archivi, le raccolte miste, documentarie, librarie, museali, botaniche. Si pensi alla possibilità di illustrare con meccanismi olfattivi ad esempio raccolte botaniche e illustrarne nel contempo in modo multimediale i cartigli tecnici, le caratteristiche visive, le proprietà documentate da erbari e schede botaniche, spesso conservati in archivi locali, siano essi comunali, siano essi parrocchiali o privati.
Ma veniamo alla categoria dei giovani e di coloro che non cercano nel volontariato una nuova possibilità di impegno post-lavorativo, come fa sempre più spesso il meno giovane, stanco del gratificante ma per certi versi anche avvilente ruolo di nonno-babysitter, ma un arricchimento vero dal punto di vista formativo e lavorativo: i giovani. Si pensi a quanti studenti delle scuole superiori e delle università si avvicinano al nostro mondo in occasione di stages e tirocini formativi, accostandosi con grande meraviglia, spesso con vero profondo stupore, a un mondo sconosciuto, quello delle fonti che sino a quel momento hanno appreso solo dai libri di testo e che grazie all'attività promossa dall'istituto dell'alternanza scuola-lavoro o dai tirocini possono finalmente toccare con mano: si tratta di una forma, se vogliamo, di volontariato indotta, meno spontanea forse, ma sicuramente stimolante e propedeutica alla conoscenza "vera" e concreta di un mondo ai loro occhi sino a quel momento non reale, bensì virtuale, al pari della realtà che imparano a conoscere fin dalla più tenera età tramite internet e giochi come le play stations e che spesso creano in loro confusione identitaria e alienazione sociale.
Toccando con mano, annusando, respirando i documenti cartacei o pergamenacei, i volontari si tuffano in un mondo sconosciuto ma molto più tangibile di quello della rete, in un mondo che apre loro altre prospettive e che rischia di appassionarli: da quei giovani spesso sbocciano i volontari del dopo-adolescenza, i tanti giovani che vogliono approfondire e che son disposti a investire il loro tempo nella schedatura di fotografie, manifesti, disegni, libri, giornali, materiale in qualche modo atipico, cui spesso gli addetti ai lavori non hanno tempo da dedicare, oberati come sono dai carichi di lavoro quotidiani spesso insostenibili a causa della scarsità di personale. Lavori, quelli affidati a tali volontari, apparentemente minori, ma importanti per la formazione professionale dei volontari e per il censimento e la valorizzazione delle fonti stesse, destinate spesso a una forma di apartheid documentale.
Altrettanto importante è l'esperienza che possono fare i giovani (e non solo) nei lavori di indicizzazione di inventari e schedari, spesso ricchi di nomi e di elementi specifici che vanno tesaurizzati per comprenderne a fondo la potenzialità: si pensi agli indici delle parti contraenti degli atti notarili, o ai repertori catastali, agli indici di catastici, o ancora a toponimi e indici onomastici legati a mappe o a lavori edilizi (commissioni d'ornato o edilizia pubblica), o legati a inventari dotali, a fascicoli personali di "maniaci" o "esposti", a cartelle cliniche, o a fascicoli personali di studenti, insegnanti, etc. Non si tratta di lavori riservati unicamente ad addetti ai lavori dotati di preparazione e formazione specifica, ma di lavori semplici, cui anche il neofita può avvicinarsi senza timore ma con curiosità e passione, partendo da corsi di formazione di base che forniscano loro le "armi" per la comprensione del lavoro che andranno a svolgere.
Se ne ottiene senza grandi sforzi e senza spreco di risorse economiche un coinvolgimento di risorse volontarie in un'attività che è soprattutto di valorizzazione e che può sfociare nella collaborazione con enti locali, archivi di stato, aziende, all'allestimento di mostre, pubblicazioni, percorsi didattici che arricchiscono l'offerta di servizi da parte delle istituzioni stesse, proprio grazie all'apporto di chi ha un approccio non istituzionalizzato con la ricerca e lo studio e che può mettere a frutto le proprie potenzialità (informatiche, grafiche, multimediali, artistiche) nella creazione di un valore aggiunto, quello della valorizzazione del bene culturale.
Speciale MAB e volontariato - pag. 17 [2012 - N.44]