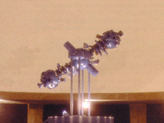Il restauro di un trittico carmelitano
È quasi compiuto il restauro di un'importante opera di Nicolò Rondinelli, conservata al Museo d'Arte della Città di Ravenna
Nadia Ceroni - Conservatore Museo d'Arte della Città di Ravenna
I complessi lavori di restauro, che si sono resi necessari per ripristinare tre tavole di Nicolò Rondinelli, il maggiore artista ravennate del Quattrocento, stanno per terminare. L'opera, conservata nella Pinacoteca del Museo d'Arte della Città di Ravenna, è stata affidata alle cure del laboratorio di Sandro Salemme di Imola, esperto restauratore di opere d'arte su legno.Finanziato dall'IBC per conto della Regione Emilia-Romagna (legge 18/2000), l'intervento ha richiesto analisi chimiche, realizzate grazie alla collaborazione del personale tecnico della Soprintendenza di Bologna, e indagini diagnostiche, eseguite grazie alla disponibilità dell'Enea di Bologna. Per le ricerche storico-artistiche, la Pinacoteca ravennate ha potuto contare sulla collaborazione del Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Bologna-Sede di Ravenna: il restauro del trittico del Rondinelli sarà infatti oggetto di una tesi di laurea.
Le tre tavole - entrate a far parte del patrimonio artistico della Galleria dell'Accademia di Belle Arti, attuale Pinacoteca, nel 1906 - provengono dalla Chiesa di San Giovanni Battista, detta anche "dalle Catene" o "della Cipolla". Raffigurano una Madonna in trono con il Bambino e i Santi Alberto e Sebastiano. Giorgio Vasari, nelle Vite de' più eccellenti pittori, ed. 1550 e 1568, a proposito della produzione artistica del Rondinelli, menzionava l'opera con parole d'elogio: "Quella che passò tutte le altre opere sue, fu quella che fece nella chiesa di San Giovanni Battista […] dove stanno i Frati Carmelitani, nella quale, oltre la Nostra Donna, fece nella figura d'un Sant'Alberto loro frate una testa bellissima e tutta la figura lodata molto".
Nella chiesa il trittico era segnalato fino al 1821; veniva poi ritirato dai conti Lovatelli per essere collocato nel loro palazzo fino al 1904, anno in cui passava in deposito all'Accademia per essere definitivamente acquisito al patrimonio artistico dell'Istituzione nel 1906. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che il trittico nel XVII secolo venne riunito in un grande quadro rettangolare. Ce ne dà notizia Corrado Ricci nelle Raccolte artistiche di Ravenna (1905), puntualizzando sul fatto che "si alzò la tavola con la Vergine apponendovi due assicelle laterali dipinte ad angeli e serafini e si misero sotto i due Santi, frammettendo però loro un'aggiunta con un po' di paese". La presenza degli angeli, e quindi dell'opera nella sua forma rettangolare, è confermata nelle guide di Ravenna di F. Beltrami (1783 e 1791), di F. Nanni (1821) e di G. Ribuffi (1835).
Dalle indagini finora svolte, sappiamo che nel 1834 la testa di Sant'Alberto era stata irrimediabilmente compromessa da un intervento di restauro (F. Mordani, 1874) e che nel 1914 le singole tavole venivano nuovamente separate. Mancano notizie sulle aggiunte del Seicento e sulla presenza dell'opera in chiesa, ricordata brevemente sul terzo altare a destra: poiché Sant'Alberto era un frate carmelitano, si potrebbe ipotizzare che le tre tavole siano state appositamente realizzate per San Giovanni Battista, antica chiesa dell'ordine, riedificata a tre navate dall'architetto Pietro Grossi nel 1683. L'ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla testimonianza del Fabri nei Lustri Ravennati ( 1678) che a proposito di quest'opera affermava: "Questa, nel tempo c'hora scriviamo, minacciando rovina, si può dire che non si ristaura ma che si riedifica per opera del Padre Maestro Lorenzo Bongiovanni Ravennate".
Un altro motivo di indagine, sul quale le ricerche in corso potranno far luce, riguarda il momento relativo all'acquisizione dell'opera del Rondinelli da parte della Pinacoteca. Sappiamo infatti che venne ceduta alla Galleria ravennate dal Ministero dell'Istruzione, in cambio di un piccolo trittico, già attribuito a Fiorenzo di Lorenzo e poi ad Antoniazzo Romano, trasferito alla Galleria degli Uffizi. A conclusione dei lavori di restauro, si darà conto delle indagini in corso e dell'acquisizione di nuove informazioni, fondamentali per la conoscenza storico-artistica e la valorizzazione di un'opera tra le più importanti della collezione antica della Pinacoteca.
Come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, tra le attività istituzionali quella relativa alla conservazione si conferma tra le più significative, essendo spesso occasione di "rivelazione dell'artista, dei soggetti rappresentati e della storia dell'opera".
Speciale restauro - pag. 13 [2004 - N.19]