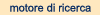|
Il paesaggio, come genere pittorico, venne praticato in maniera sistematica a partire dal XVI secolo, quando uno scenario naturale autonomo, più o meno fantasioso e d’invenzione, venne ammesso fra i possibili soggetti della pittura.
Prima considerato come genere minore, divenne poi elemento indispensabile per la narrazione di gesta, passioni e stati d’animo fino ad essere considerato soggetto autonomo e sperimentale. Prediletto dagli inpressionisti nella seconda metà del XIX secolo, l’amore per il paesaggio caratterizza, nei primi anni del XX secolo, la poetica dei fauves e focalizza le attenzioni di numerosi protagonisti del Novecento italiano – tra cui Morandi, Carrà, De Chirico, Sironi, Rosai, De Pisis – fino ad approdare alla nuova interpretazione in termini emozionali, come puro colore-luce, offerta da svariati rappresentanti del linguaggio informale.
Un aspetto particolare di questo genere artistico è rappresentato dall’ambiente naturalistico delle pinete, ben documentato nella collezione moderna del Museo d’Arte della Città, che raccoglie ed espone numerose opere rappresentative del paesaggio ravennate. Ai quadri di Moradei, Miserochi, Bacchetti, Mazzetti – solo per citarne alcuni – si aggiungono le acqueforti di Vittorio Guaccimanni, valente artista ravennate, direttore ed insegnante di figura nella locale Accademia di Belle Arti.
Delle 145 incisioni, che costituiscono l’intero nucleo grafico, una cinquantina sono dedicate al tema delle pinete e del relativo habitat, in cui si muovono pochi animali e ancora più rare persone.
Di varie dimensioni, spesso nella duplice versione nera e a colori, rappresentano un aspetto della produzione artistica dell’artista ravennate che, pur impegnato in varie tecniche – pittura ad olio, all’acquerello, a pastello – nell’incisione fu maestro a Gaspare Gambi. In relazione alle disposizioni testamentarie del defunto conte Vittorio Guaccimanni, l’intero corpus – 80 acqueforti nere e 65 colorate – venne depositato nell’Accademia dalla Signora Adalgisa Caserta nel 1938. La raccolta, attualmente non esposta al pubblico, a causa degli insufficienti spazi espositivi destinati al patrimonio museale permanente all’interno della Loggetta Lombardesca, ci permette di conoscere il nostro artista anche quale sensibilissimo incisore, oltre che pittore, disegnatore e miniaturista di grande raffinatezza.
Spiace constatare come a questo artista – ben documentato a Ravenna non solo al museo, ma anche in collezioni private e nella Quadreria della Biblioteca Classense – non sia stata dedicata una strada a futura memoria della sua attività e di quella del fratello Alessandro, entrambi allievi dell’Accademia.
Al nucleo delle incisioni, nel 1988 fu dedicata una mostra, allestita nella chiesa di Santa Maria delle Croci ma, come suggerisce Giordano Viroli “data la statura del personaggio, par lecito attendersi la realizzazione di un catalogo dedicato alla sua opera pittorica, che consenta a Guaccimanni di ricevere finalmente l’attenzione che gli spetta”.
Alla tematica delle pinete si collega anche un’altra opera conservata nella collezione antica del museo. La storia di ogni quadro riserva spesso curiosità e informazioni che una lettura superficiale non permette di valorizzare e far conoscere adeguatamente. È il caso del Redentore di Paris Bordon, artista veneto del XVI secolo, allievo del grande Tiziano. L’opera in questione, che apparteneva al mercante veneziano Andrea Cornaro, nel 1766 pervenne ai monaci camaldolesi di Classe. Dopo le soppressioni delle corporazioni religiose, passò alla famiglia Rasi e nel 1922 giunse per disposizione testamentaria al Comune di Ravenna tramite la signora Sofia Baccarini, vedova dell’ingegnere Claudio Rasi.
In un suo articolo del 1928 – intitolato Le vicende di un quadro famoso – Silvio Bernicoli riferiva che il dipinto era pervenuto ai monaci quale risarcimento per l’insolvenza di varie partite di pinoli acquistati dal nobile veneziano presso il monastero di Classe.
Da questo cenobio, possesore di pinete e di terreni vastissimi, il Cornaro si faceva spedire grandi quantità di pignoli, fagiuoli e formentone. Trovandosi a corto di denaro, ma con grande disponibilità di oggetti preziosi da museo, propose ai monaci di valersi di questi beni per colmare il proprio debito.
Piccole vicende artistiche che contribuiscono a rendere ancor più indissolubile il legame delle pinete ravennati con la storia e la cultura di Ravenna.
|
|