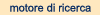|
L'interesse archeologico della Pieve del Th˛ (San Giovanni Battista in Ottavo), presso Brisighella, e del sito sul quale sorge Ŕ dovuto a due fatti: a) la presenza (al pari di quanto si constata in altre pievi dell'entroterra ravennate istituite in luoghi nei quali il culto cristiano si era radicato giÓ nei secoli dell'Alto Medioevo) di materiale romano di spoglio inglobato nelle strutture architettoniche; b) l'esistenza in seguito agli scavi condotti nell'edificio soprattutto tra il 1951 e il 1967 (con riprese di minor importanza sino al 1979-1980) di una raccolta di frammenti e manufatti di varia natura e datazione recuperati durante i lavori e collocati - fino a qualche anno fa - negli ambienti (adibiti ad antiquarium ) ricavati al di sotto dell'attuale pavimento della chiesa. a) Gli elementi archeologici di maggior rilevanza usati nell'erezione della chiesa romanica (che doveva essere compiuta nel 1100) sono: una colonna in marmo rosa di Verona (quinta della fila di sinistra) e otto in granito orientale su una delle quali (quarta della fila destra) Ŕ incisa una iscrizione che ricorda gli imperatori Valente, Valentiniano e Graziano (376-378). Inoltre alcune basi di colonne e sette capitelli in parte rilavorati la datazione dei quali si scala dal I secolo a. C. (grande capitello usato come acquasantiera) al III-IV secolo (quattro capitelli, sulla quarta e sulla quinta colonna della fila sinistra e sulla terza e sulla quinta colonna della fila destra) e al V-VI secolo (due capitelli sulla terza e sulla sesta colonna di sinistra, sul primo dei quali Ŕ scolpita una croce). Nelle strutture murarie sono stati inglobati frammenti di epigrafi (nella controfacciata, lato nord forse appartenente a un sargofago e sulla parete di fondo della navata destra). A questi cospicui elementi reimpiegati si devono aggiungere elementi dell'arredo liturgico fisso appartenenti alla fase storica della chiesa precedente l'erezione dell'attuale (che va collocata tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo). Si cita in particolare il bassorilievo che funge ora da paliotto dell'altar maggiore raffigurante Cristo seduto tra due angeli, due palme e due agnelli riferito all'VIII-IX secolo murato forse nel XVI secolo al di sopra della porta di ingresso e due frammenti appartenenti ad un pulvino (con una croce tra elementi fitomorfi) giÓ murati sull'arco di accesso alla canonica e databili al VI-VII secolo. b) La raccolta di reperti recuperati durante gli scavi e ricoverata nell'antiquarium Ŕ attualmente in restauro da parte della Soprintendenza Archeologica di Bologna (restauratrice Ardea Fabbri, direzione scientifica dr.ssa Chiara Guarnieri). I risultati di tale lavoro potranno fornire indicazioni per un nuovo progetto espositivo dei pezzi. Va ricordato che gli scavi condotti tra il 1951 e il 1967 vennero eseguiti secondo la prassi allora corrente, ossia senza procedere alla ricognizione per unitÓ stratigrafiche normalmente seguita oggi insieme alla registrazione dell'andamento del lavoro su diario di scavo. L'assenza di tale documentazione rende non facile una esposizione del materiale che voglia proporre una lettura didatticamente chiara dei reperti e non un semplice allestimento antologico dei pezzi. Lo scavo individu˛ la presenza di un insediamento romano nel sito sul quale sorse la chiesa, forse una villa della quale si Ŕ trovata traccia della sua pars fructuaria . Si rinvennero infatti otto dolii al di sotto della attuale navata destra a 2,20 metri di profonditÓ e altri quattro nella attigua corte interna presso il pozzo. A tale momento dovrebbe appartenere anche il pozzo con drenaggio messo in luce in corrispondenza della terza arcata interpretato da taluni come piccolo forno o fornace (ma da altri come "celletta per cure termali"). Ad un livello pi¨ alto della celletta venne messa in luce una tomba con un inumato priva di corredo e un muro formato da mattoni romani e da sassi regolari che si sviluppa per una lunghezza quasi pari alla navata. Si tratta di elementi cronologicamente precedenti il primitivo edificio di culto cristiano messo in luce al di sotto dell'abside attuale usato forse come cripta della chiesa eretta in etÓ romanica (alla fine del sec. XI - inizi sec. XII) e colmato con materiale eterogeneo forse solo nel XVI secolo quando la costruzione venne aumentata di due arcate e assunse l'aspetto attuale. La lettura di tale ambiente (riferito da taluni al VI secolo) Ŕ controversa: l'esame della tessitura muraria (che ingloba anche materiale romano come una tabula lusoria inserita nel muro a sinistra dell'ingresso originario) non esclude che l'absidiola semicircolare della cripta possa esser stata aggiunta in un momento successivo ad un originario impianto a semplice aula rettangolare con annessa una stanza di disimpegno a pianta quadrata ("camera della colonna"). La cripta doveva avere una copertura a volte sorretta da sei colonne come Ŕ dimostrato dal ritrovamento di alcune basi sul pavimento originario. Anche se le opinioni a tal proposito non sono concordi si dovrebbe escludere la continuitÓ d'uso tra impianti architettonici romani e il primitivo edificio di culto cristiano: va poi ricordato che i pezzi ritrovati nello scavo (usati come materiali di riempimento) non sono necessariamente originari del sito. E' possibile che nella zona -forse giÓ in epoca preromana- fossero vivi culti dedicati a divinitÓ delle acque salubri assorbiti poi nel sistema religioso romano e "santificati" successivamente dall'innestarsi del culto cristiano. A tal proposito Ŕ stata richiamato come spia significativa il toponimo "in Feroni" associato alla chiesa negli antichi documenti che potrebbe essere eco di un antico culto a Feronia. Oltre ai dolii sopra ricordati, i reperti pi¨ significativi provenienti dallo scavo sono: un frammento di stele con iscrizione agli Dei Mani, una macina da frantoio, elementi romboidali di pavimentazione in cotto, mattoni manubriati, lacerti di intonaci affrescati, un elemento in marmo bianco a forma di grata o feritoia, frammenti di vetri e di anfore e frammenti appartenenti a un pluteo del IX secolo con intrecci e grappoli d'uva e croce greca. Insieme ai materiali romani e altomedioevali gli scavi portarono alla luce anche manufatti pi¨ recenti (ceramiche e materiali da ricollegarsi al riempimento eseguito nel 1570-1572 per innalzare il pavimento della chiesa).
|
|